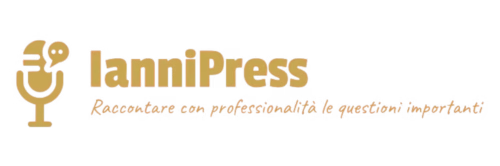Ludopatia e l’azzardo di giocarsi la salute

Conquiste del Lavoro – Anno 2023 – 2 Dicembre
Quando il gioco d’azzardo sfocia in un comportamento problematico o in una dipendenza, è fondamentale rivolgersi ad uno specialista per chiedere aiuto e supporto. È importante sapere che, come per molte altre patologie, anche per il Disturbo da Gioco d’Azzardo, più precoce è l’intervento terapeutico, maggiore è la possibilità di avere buoni risultati e di risolvere il problema. Purtroppo, solo un ludopatico su cento decide di curarsi. A metterlo in evidenza è l’Agenzia di tutela della salute (ATS) e si stima che sul territorio bresciano 26mila persone soffrano di Disturbo da gioco d’azzardo, ma sono molte meno quelle prese in cura: 344 nel 2022 e 274 nel primo semestre del 2023. Di fronte a questa evidenza e per provare a combattere il fenomeno Ats Brescia ha affidato al Centro di ricerca (Cerisvico) dell’Università Cattolica il progetto di ricerca-intervento ‘Promuovere salute di comunità e fronteggiare il Gioco d’azzardo Patologico (Gap)’. Alcuni giocatori arrivano a vendere casa compromettendo i rapporti familiari. Inoltre, queste persone faticano a riconoscere l’esistenza del problema. Diventa quindi difficoltoso agganciare queste persone e trovare al tempo stesso la strategia migliore per intercettare i malati. Molti non si fanno curare perché non riconoscono di avere un problema. In particolare, i giovani, visto che la fascia più colpita è quella degli under 25. Il Gioco d’Azzardo Patologico è un fenomeno arduo da intercettare e monitorare. Cruciale mettere in atto una ricerca-intervento volta a valorizzare le risorse e le reti già presenti nel territorio, potenziarle e, insieme ad esse, sensibilizzare e attivare tutti gli attori della comunità territoriale. La ricerca ha consentito di rilevare diversi punti di vista e articolarli in un quadro composito e condiviso, facendo emergere la complessità del fenomeno. Gli esiti sono stati molteplici: una lettura della salute di comunità nel territorio realizzata con le persone che abitano nel territorio; l’aumento della consapevolezza in merito alle risorse e alle potenzialità del territorio; l’attivazione di cittadini, organizzazioni e il rafforzamento di reti locali per la promozione della salute di comunità; l’aumento del senso di appartenenza (e di comunità) e della coesione sociale, nonché l’au mento di capitale sociale tra i cittadini e le istituzioni. C’è stata una modalità dialogico-partecipativa e ha coinvolto nel corso di questi 3 anni di lavoro quasi 1000 partecipanti tra operatori, coordinatori e responsabili delle varie istituzioni che si occupano attivamente del tema, famigliari e utenti dei servizi, punti comunità, realtà che si occupano di fragilità, assessori, stakeholder del territorio (impiegati di banca, medici di base medico, parrocchia, referenti scolastici), esercenti, sindacati, cittadini, studenti. Tutto è stato accompagnato da video-narrazioni per dare maggiore visibilità al prezioso contributo di tutti nella riflessione sulla comunità.